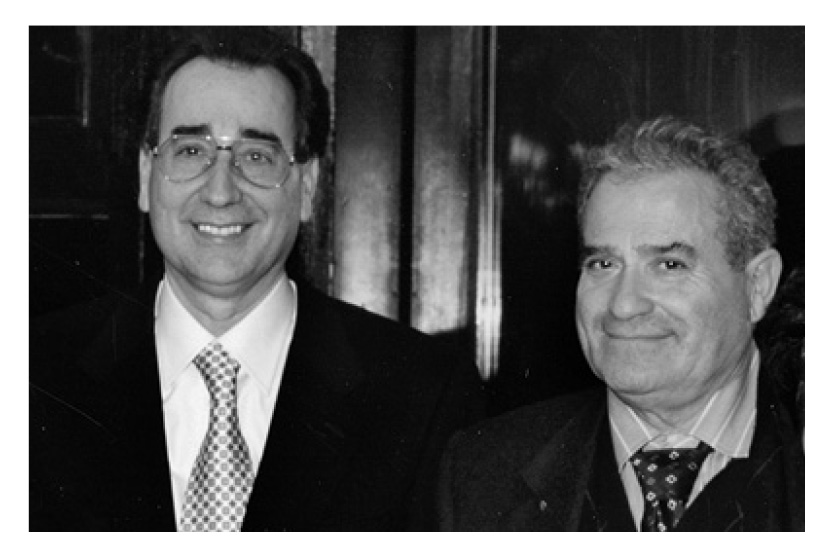Per arare avevamo bisogno di tre paia di mucche: il primo paio era attaccato all’aratro e lo guidava mio padre; il secondo mio fratello o mia sorella; il terzo paio lo portavo io. Con l’avvicinarsi delle sette del mattino, iniziavamo tutti a voltare gli sguardi verso casa per vedere se la mamma stesse venendo a portarci la colazione. Quando poi lei arrivava con la cesta in testa, stendeva la tovaglia a terra e ci posava il pane, quasi sempre accompagnato da zucca cotta con pancetta e un frutto di stagione.
Poi si ricominciava subito a lavorare ed io chiedevo sempre a mio fratello quando avremmo finito; lui conficcava la vanga in un punto del terreno e mi diceva: “Quando arriviamo qui smettiamo.” Ma non era mai di parola. Quando raggiungevamo la vanga, lui puntualmente la spostava più in là; io mi arrabbiavo e piangevo; avevo dieci o dodici anni. La pietà a quei tempi non esisteva. Quando tornavi a casa, dopo il duro lavoro nei campi, bisognava ancora accudire le mucche, i maiali, le pecore e i conigli.
Un giorno scoprimmo un vespaio.
All’improvviso un nuvolone di vespe era sbucato dal terreno, lanciandosi prima tra le gambe di mio padre per poi attaccare le mucche, me e mia sorella. Non so quante vespe abbiano punto tutti noi, ma erano così tante che non riuscivamo a sganciare le mucche dall’aratro. Ci è voluto tutto il coraggio e il sangue freddo di mio padre e comunque dovemmo aspettare che facesse sera, affinché le vespe tornassero nel loro nido, per ucciderle e riprendere possesso del nostro aratro, che era rimasto sul campo.
Vi domanderete come abbiamo fatto a sterminare circa duemila vespe; semplicissimo! Abbiamo preso un imbuto, un secchio d’acqua bollente e l’abbiamo rovesciato nell’apertura del vespaio. Come potete vedere, i contadini sapevano sempre come difendersi.
Nel 1952 mia sorella Viola si sposò, così in casa ci ritrovammo con due braccia in meno per lavorare. La vita dei campi era sempre uguale, si lavorava 15-16 ore al giorno senza mai vedere una lira e i conti tornavano sempre al padrone.
E arrivammo al 1956.
M padre soffriva di ulcera gastrica, tanto che decise di operarsi, cogliendo l’occasione che mio fratello Enrico era tornato in convalescenza dal servizio militare. Era dicembre e lui decise di andarsi ad operare a Sant’Elpidio a Mare; non l’avesse mai fatto. Il 19 dicembre del 1956, a soli cinquant’anni, mio padre morì per incuria dei medici. Non potete immaginare il dolore e la disperazione di mia madre e di noi tutti. Eravamo rimasti in tre per dieci ettari di terra, senza soldi e senz’altro.
Per pagare il funerale dovemmo vendere quel po’ di grano che ci sarebbe servito per vivere fino al giugno successivo. Sapeste che dolore provai la mattina che mio cognato Alessandro mi riportò a casa, dopo che avevo pernottato da un vicino.
Arrivammo alle sei del mattino, era buio pesto e faceva freddo, mio cognato non aveva avuto il coraggio di dirmi che mio padre era morto. Quando arrivai sotto la finestra della camera di mio padre, sentii che la casa era piena di gente che recitava il rosario; a quel punto capii tutto e svenni.
Avevo esattamente tredici anni.